I soldi fanno la felicità?
Non c’è mese che passa che un nuovo studio di qualche economista voglia convincerci che i soldi fanno la felicità. L’ultimo è quello del premio Nobel Daniel Kahneman, che con Matt Killingsworth, sostiene che anche per il 15% della popolazione più misera degli Stati Uniti il denaro produce effetti positivi fino a 100mila dollari, mentre per la restante popolazione (che registra livelli di felicità medi, buoni e ottimi), l’effetto “tetto” non esiste: più denaro dà sempre più felicità. Lorenzo Dornetti, Ceo di Neurovendita, società privata di neuroscienze (uno “scienziato” con interessi a vendere) si azzarda a dire «con queste scoperte si mette un punto al dibattito che contrapponeva la crescita del Pil al benessere delle persone». Il giornalista de Il Sole 24 Ore che gli pare aver riportato forse una castroneria aggiunge: «È bene ricordare però che il denaro è solo una delle variabili con impatto positivo sulla felicità; c’è la rete delle relazioni affettive, la soddisfazione sul lavoro, la sfera della spiritualità, tutti elementi che influiscono positivamente sul livello di felicità. Per questo, forse, è ancora troppo presto per parlare dei soldi come ricetta della felicità».
Alcuni anni fa un’altra ricerca aveva dimostrato (più credibilmente) che fino a 40mila euro di reddito annuo c’era una certa correlazione tra felicità e soldi. E te lo credo… si fa dura nella nostra società dove vige il “dio quattrino” al posto di quello trino (sparito) a essere felici con 10mila euro all’anno e il water rotto, anche se i nostri amici francescani già non sarebbero d’accordo e se fosse vero dovremmo presto cambiare il patrono d’Italia che è san Francesco.
Gli indici della felicità per nazioni dicono che i più felici sono in Islanda, Svezia, Svizzera e Norvegia, ma se si introducono altri parametri (anni di vita, impronta ecologica, perché è anche bello essere felici senza smerdare o sfruttare il resto del mondo) allora altre ricerche dicono che sono quelli di Vanuatu e Costa Rica e un nuovo studio del 2023 mostra che società con redditi molto bassi hanno elevati livelli di soddisfazione della vita, paragonabili a quelli dei Paesi ricchi! La crescita economica viene spesso vista come il solo modo per aumentare il benessere delle persone nei Paesi a basso reddito, e negli ultimi decenni le indagini globali hanno supportato questa convinzione, mostrando che le persone nei paesi ad alto reddito tendono a dichiarare livelli di soddisfazione per il loro stile di vita più elevati rispetto a quelli dei Paesi a basso reddito. Si vuol far credere che solo le società ricche possono essere felici.
Ma il nuovo studio High life satisfaction despite low income, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) da un team internazionale di ricercatori guidato dall’ICTAUAB de Barcelona e McGill University dubita che questa relazione sia universale e corrobora il vecchio detto che «non sono i soldi a fare la felicità».
I ricercatori fanno notare che «la maggior parte delle indagini globali, come il World Happiness Report, raccolgono migliaia di risposte da parte dei cittadini delle società industrializzate, ma trascurano gli abitanti delle società piccole e marginali, dove lo scambio di denaro esercita un ruolo minimo nella vita e il cui sostentamento dipende direttamente dalla natura».
Lo studio pubblicato su PNAS ha coinvolto 2.966 persone che vivono in 19 comunità indigene in tutto il mondo e solo il 64% disponeva di un reddito monetario. Il principale autore dello studio, Eric Galbraith, sottolinea che «i risultati mostrano che, sorprendentemente, molte popolazioni con redditi monetari molto bassi dichiarano livelli molto elevati di soddisfazione di vita, con punteggi simili a quelli dei Paesi ricchi».
Il punteggio medio di soddisfazione per la vita nelle piccole società umane studiate era 6,8 su una scala da 0 a 10. I ricercatori evidenziano che «sebbene non tutte le società abbiano riferito di essere molto soddisfatte (la media più bassa ha raggiunto 5,1), quattro dei luoghi hanno registrato punteggi medi superiori a 8, tipici dei ricchi Paesi scandinavi in altre indagini. I risultati concordano con l’idea che le società umane possono offrire una vita molto soddisfacente ai propri membri senza necessariamente avere elevati livelli di ricchezza materiale misurata in termini monetari».
L’altro autore principale dello studio, Victoria Reyes-García, aggiunge che «la forte correlazione che spesso si osserva tra reddito e soddisfazione per la vita non è universale e dimostra che la ricchezza, così come generata dalle economie industrializzate, non è un requisito fondamentale affinché gli esseri umani abbiano una vita felice».
Galbraith conclude: «Sebbene ormai sappiamo che gli abitanti di molte società indigene si dichiarano molto soddisfatti della propria vita, non ne sappiamo il motivo». Lavori precedenti suggeriscono che il sostegno reciproco, le relazioni familiari e sociali, la spiritualità e il legame con la natura sono fattori importanti da cui dipende tale felicità.
Per Tolstoj (“La felicità familiare”, 1859) la felicità è reale solo se condivisa. Lo ripeteva anche il personaggio di Christopher McCandless nel monologo finale del film Into the wild (2007) e lo sostengono oggi i ricercatori dell’Harvard Study of Adult Development: uno studio longitudinale avviato alla fine degli anni ’30 con l’obiettivo di rintracciare i fattori che generano soddisfazione per la propria vita, identificando le variabili psicosociali e i processi biologici dei primi anni di vita e dell’età adulta capaci di predire salute e benessere in tarda età.
I ricercatori hanno seguito per 85 anni un campione di 724 partecipanti (tutti maschi), analizzando il loro comportamento e quello di 1.300 discendenti, nel corso di tre generazioni.
Uomini di diversa estrazione economica e sociale, dai quartieri più poveri di Boston a studenti universitari di Harvard (tra cui anche John F.
Kennedy). Raccolte migliaia di informazioni su salute, benessere mentale ed emotivo, analisi di cartelle cliniche, interviste e questionari ogni due anni.
È emerso che l’ingrediente principale della felicità non è il denaro, la carriera o il prendersi cura della propria salute, ma la capacità di coltivare relazioni sociali di qualità: le interazioni “piccole” e quotidiane con i colleghi di lavoro, i vicini di casa, gli amici (quelli veri non dei social), le relazioni sentimentali, i legami familiari. Più forti, autentiche e positive sono queste relazioni, più è probabile che la vita e la vecchiaia siano più appaganti e più sane. «Le persone che apparivano più soddisfatte nelle loro relazioni all’età di 50 anni erano le più sane all’età di 80 anni», dichiara Robert Waldinger, principale autore dello studio con Marc Schulz.
Le conclusioni sono nel libro The Good Life: Lessons from the World’s Longest Study on Happiness (2023). Le storie dei partecipanti, integrate da altre ricerche longitudinali, sottolineano il valore delle connessioni umane come fattore in grado di proteggere le persone dall’insoddisfazione, ritardare il declino mentale e fisico e concorrere a vite lunghe e felici, molto più della classe sociale, quoziente intellettivo, genetica e dei soldi.
Gli autori sottolineano che non è mai troppo tardi per uscire dalla solitudine e intrecciare legami affettivi. È vero che i tuoi geni e le tue esperienze modellano il modo in cui vedi il mondo, in cui interagisci con le altre persone e in cui rispondi ai sentimenti negativi. Ed è vero che le opportunità di avanzamento economico non sono ugualmente disponibili per tutti, e alcuni di noi nascono in posizioni di svantaggio. Ma i tuoi modi di stare al mondo non sono scolpiti nella pietra. La tua infanzia non è il tuo destino.
La tua disposizione naturale non è il tuo destino.
Il quartiere in cui sei cresciuto non è il tuo destino. La ricerca lo dimostra. Nulla di ciò che è accaduto nella tua vita ti preclude di connetterti con gli altri, di prosperare e di essere felice. Le persone spesso pensano che una volta raggiunta l’età adulta, è finita: la tua vita e il tuo modo di vivere sono impostati. Ma quello che troviamo esaminando la ricerca sullo sviluppo degli adulti è che questo non è vero. È possibile un cambiamento significativo (fonti: The Harvard Study of Adult Development, What decades of research tells us about living the good life).
I risultati di questo studio (più di quello di Kahneman) rappresentano buone notizie, perché forniscono una solida prova del fatto che per raggiungere un benessere soggettivo non è necessaria una crescita economica ad alta intensità di risorse. Più che degli economisti capiscono la vita scrittori come Tolstoj o Thomas Merton (Nessun uomo è un’isola) o Ludovico Ariosto di cui riporto un brano tratto dall’Orlando furioso:
La felicità: «Quella, tu dici, che inseguii, non era lei…? No: era una vana ombra in sembiante di quella che ciascuno ama e che spera e che perde. Virtù di negromante! Ella è qui, nel castello arduo ch’entrai? Forse la tocchi, o cavaliere errante! Forse… E non la vedrò? Non la vedrai. Oh! Tale è l’arte dell’oscuro Atlante: non è, la vedi: è, non la vedi. E, mai…? Ma sì: se leggi in questo libro tante rapide righe. E dicono…? S’ignora: chi lesse tacque, o cavaliere errante! Se leggo… sai: l’incanto è rotto. Allora? La vedrai. Su l’istante? in quell’istante! E il castello? Nell’ombra esso vapora. Ed è… la vita o cavaliere errante!».
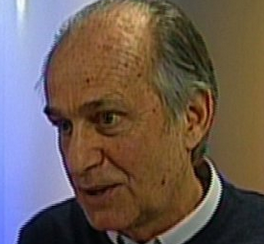
Andrea Gandini
Economista, già docente di economia aziendale, università di Ferrara,
con la quale collabora per la transizione al lavoro dei laureandi, componente la redazione di
madrugada, si occupa di scultura e giochi di legno per bambini e adulti.
